 |
Fig.
1 - Cascata
di pieghe a zig-zag nella Formazione
Marnoso-arenacea a strati verticali, Fiume Santerno
presso Coniale. (foto A. Landuzzi) |
|
|

|
Fig.
2 - La
Vena del Gesso sul versante
sinistro del Santerno. (foto G.B. Vai) |
|
|

|
Fig.
3 - Le due
scaglie a banchi gessosi di Monte Incisa e Co' di
Sasso sovrapposte tettonicamente e separate dalla
Formazione Marnoso-arenacea, nel bosco, da cui emerge
una grande massa bianca isolata di calcare a Lucina.
(foto G.P. Costa) |
|
|

|
Fig.
4 - Fenditura
in un banco di gesso (a destra dell'asta con tacche di
20 cm), riempita da gesso ricristallizzato a grandi
cristalli limpidi. (foto G.B. Vai) |
|
|

|
Fig.
5 - Sericolite
o gesso fibroso di faglia, Cava ANIC. (foto G.B. Vai) |
|
|
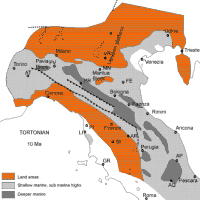 |
Fig.
6 - Schizzo
paleogeografico del Nord-Italia nel Tortoniano
(ca.10 milioni di anni). In marron le aree emerse,
dal grigio chiaro al grigio scuro i mari a profondità
crescente. (da Vai, 1988) |
|
|
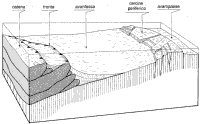 |
Fig.
7 - Denominazione,
assetto e evoluzione delle varie porzioni che
costituivano l'antico bacino adriatico. (da Vai,
1989 mod.) |
|
|

|
Fig.
8 - Calcare
a Lucina, grossi bivalvi marini, cresciuti in gran
numero anche a profondità considerevoli presso
venute di gas ricche di metano nutritivo. (foto G.B.
Vai) |
|
|
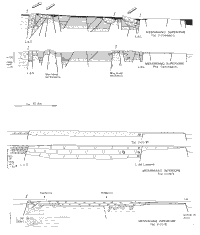 |
Fig.
9 - Evoluzione
sedimentaria e paleotettonica della Vena del Gesso
romagnola durante il Messiniano tra il Sillaro e il
Forlivese. (da Marabini & Vai, 1985) |
|
|
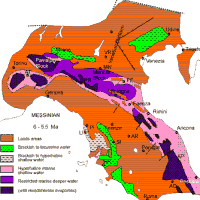 |
Fig.
10 - Schizzo
paleogeografico del Nord-Italia nel Messimano medio
(ca. 6 - 5,5 milioni di anni). In marron le aree
emerse, in verde i laghi salmastri, dal rosa al
viola i depositi evaporitici di profondità
crescente. (da Vai, 1988) |
|
|
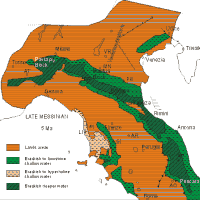
|
Fig.
11 - Schizzo
paleogeografico del Nord-Italia nel Messiniano
superiore (ca. 5 milioni di anni). In marron le aree
emerse, in rosa i depositi evaporitici, dal verde
chiaro al verde scuro i laghi salmastri di profondità
crescente. (da Vai, 1988) |
|
|
 |
Fig.
12 - La
duplicazione tettonica delle bancate gessose sul
Monte Penzola. (foto P. Lucci, Speleo GAM) |
|
|
 |
Fig.
13 - Schizzo
paleogeografico del Nord-Italia nel Pliocene
inferiore (ca. 4 milioni di anni). In marron le aree
emerse, in verde chiaro i laghi, in verde scuro i
bassifondi carbonatici, dal grigio chiaro al grigio
scuro i mari di profondità crescente. (da Vai,
1988) |
|
|
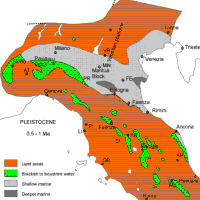 |
Fig.
14 - Schizzo
paleogeografico del Nord-Italia nel Pleistocene (ca.
0,5 - 1 milione di anni). Legenda come in Fig. 46.
(da Vai, 1988) |
|
|
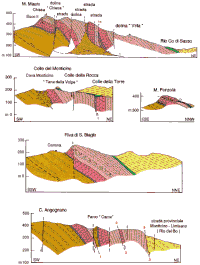 |
Fig.
15 - Sezioni
geologiche attraverso la Vena del Gesso. Per
l'ubicazione delle sezioni si veda la Carta
Geologica (da
Marabini & Vai 1985, mod.) |
|
|
Chi percorra le alte valli
dell'Appennino Romagnolo, sostando ad ammirare il panorama dalla
sommità dei crinali, ammirerà la fuga degli strati della
Marnoso-arenacea estesi a perdita d'occhio e individuabili
singolarmente. E si farà un'idea generale di una disposizione
sostanzialmente piatta o poco inclinata degli stessi (quelle
strutture che i geologi chiamano "monoclinali"). Solo
nella profondità delle valli o lungo versanti scoscesi potrà
osservare delle pieghe ad angolo retto, con improvvisi
raddrizzamenti degli strati fino alla posizione verticale. Nel caso
più fortunato, viaggiando comodamente in auto potrà sostare ad
esempio in prossimità del ponte di Coniale, risalendo la valle del
Santerno, per godere lo spettacolo di una cascata di pieghe a
zig-zag nella Marnoso-arenacea (Fig. 1).
Difficilmente però riuscirà a
vedere grandi pieghe anticlinaliche (a forma di volta) e
sinclinaliche (a forma di doccia), come è facile invece
nell'Appennino Marchigiano. Ciò non significa che l'Appennino
Romagnolo sia meno deformato di quello Marchigiano; anzi, forse è
vero l'opposto. Ma perché e come avviene la deformazione nelle
rocce? Ciò che sorprende maggiormente il pubblico, privo di
preparazione geologica, è il dovere ammettere che le rocce,
indubitabilmente formatesi in fondo al mare per i resti fossili che
contengono, si trovino assai spesso a formare alte catene di
montagne, oppure, ancor peggio, che il sollevamento conseguente
abbia comportato inarcamenti, ripiegamenti, fratture, scorrimenti
relativi di masse a stratificazione originariamente piatta. In una
parola, non è facile immaginarsi che le rocce subiscano dei
processi di deformazione meccanica, che in geologia si chiamano
tettonica. Forse per noi italiani, abituati a convivere col
terremoto, questo sforzo mentale dovrebbe essere più agevole. Dopo
un grande terremoto, porzioni di territorio al di là di una faglia
possono risultare rialzate di alcuni centimetri (fino ad alcuni
metri lungo la grande faglia attiva di San Andreas in California)
rispetto a quelle al di qua. Se il terremoto si ripete per un
migliaio di volte in 100.000 anni, per esempio, si può ottenere un
sollevamento di 100 metri, cioè una serie di colline (o di qualche
chilometro, con una vera catena di montagne in California). Per
spiegare il piegamento degli strati originariamente orizzontali
ricorriamo a un esempio banale. Un mucchio di asfalto sagomato a
forma di cubo di un metro di lato si manterrà rigido e inalterato
nel piazzale di servizio di una highway canadese nella morsa
dell'inverno artico; ma, all'improvviso arrivo dell'estate, fluirà
lentamente in modo viscoso a formare una specie di polenta nera di
alcuni metri di diametro e pochi centimetri di spessore. Basta cioè
un aumento conveniente di temperatura e un tempo sufficientemente
lungo per trasformare un materiale a comportamento rigido (e quindi
inalterabile se non viene fratturato) in uno a comportamento
plastico (e quindi modellabile nelle pieghe più sinuose, anche se
di per sé oggi ci appare rigido). L'incremento di temperatura è
fornito dal seppellimento in profondità (in media 30° C per km) e
di tempo, in geologia, lo si sa, ce n'è anche da buttare.
Volendo descrivere la storia
deformativa di evaporiti, è d'obbligo una premessa. Normalmente le
evaporiti, per la solubilità dei sali che le compongono, hanno un
comportamento estremamente plastico, facilitato anche
dall'abbondante materiale argilloso a cui sono spesso associate. Ciò
è ancora più marcato se ci sia incremento di temperatura (per
seppellimento in profondità) o di pressione (quando la roccia sia
sottoposta a sforzi deformativi). Il solo carico dei sedimenti
sovrastanti è in grado di determinare flussi viscosi nelle
evaporiti sepolte, con formazione di fittissimi arabeschi di pieghe
e intrusione a forma di cupola (detta duomo o diapiro) nei sedimenti
sovrastanti. L'insieme di questi processi viene indicato come tettonica
diapirica, che può svilupparsi anche abbastanza
indipendentemente dalla deformazione delle rocce circostanti.
Ebbene, nella Vena del Gesso ciò non
avviene. A conferma che in natura ci sono sempre eccezioni. Il
motivo principale risiede nel tipo di evaporiti (essenzialmente
gesso), nella relativa scarsità di argilla (in certe bancate il
tenore di gesso raggiunge il 95% e talora il 98%), nelle dimensioni
cospicue e nell'intreccio saldo dei cristalli, nello spessore delle
bancate evaporitiche. Tutti fattori, questi, che offrono rigidità e
resistenza al gesso. Diversamente dal solito, qui il gesso è la
roccia più solida, quella che forma i cucuzzoli e le cime più
aspre del paesaggio, quella in cui sono abbarbicati i castelli e gli
antichi abitati. Anche perché le argille, adiacenti al gesso,
vengono dilavate o avviate ai fondovalle per colata, smottamento,
scivolamento e frana, e quindi mettono in rilievo indirettamente il
gesso. Dal suo comportamento anomalo si deve anche arguire che la
Vena del Gesso non può essere stata sepolta da sedimenti prima di
essere stata deformata, perché, in caso opposto, si dovrebbero
evidenziare effetti di tettonica diapirica. Vedremo dopo se questa
affermazione trova un riscontro indipendente.
Se in un terso mattino invernale si
sorvola con un piccolo aereo la Vena del Gesso, si rimane colpiti
dalla sua frammentazione in blocchi, più marcata verso il Santerno
e il Bolognese, e da una sorta di duplicazione o addirittura
triplicazione della dorsale gessosa, ben evidente dalla valle del
Sintria al Lamone. In maniera meno eccitante, ma più economica, si
può avere analoga impressione portandosi in posizione panoramica
verso ovest lungo la statale da Borgo Tossignano a Fontanelice (Fig.
2), oppure a Tossignano, o lungo la strada
che da Zattaglia porta al Monte di Rontana (Fig. 3). Se si sceglie invece l'osservazione da
vicino, ad esempio lungo il fondovalle del Rio Sgarba o sulle alture
di Rineggio o fra i dirupi boscosi di Monte Mauro, ci si accorge che
i blocchi e le dorsali sono separati da faglia. In certi casi, come
al Rio Sgarba, queste si vedono mirabilmente disegnate sulle pareti
(occorre stare ad una certa distanza, perché, se ci si pone troppo
vicini, certe strutture non possono più essere comprese in un solo
sguardo). A mettere in risalto le faglie sono proprio le bancate
che, col loro diverso spessore o la differente composizione interna
o il colore più o meno chiaro, consentono di definire e misurare di
quanto un blocco si è spostato relativamente ad un altro (come
avviene per una strada tagliata da una fessura dopo un terremoto).
Se la fenditura che separa i due blocchi non è troppo larga,
guardandola da vicino apparirà come una vena riempita e cementata
da grandi cristalli limpidi o lattiginosi di gesso, che si
distinguono da quelli delle bancate per non avere le punte a forma
di V e per essere completamente privi dei tubuli biancastri di
rivestimento delle alghe filamentose. Essi rappresentano quindi
gesso esclusivamente secondario o tardivo che, sciolto ad opera
delle acque circolanti, ha tappezzato e riempito la cavità in un
processo detto di ricristallizzazione (Fig. 4). In altri casi le faglie non si vedono
direttamente, anche se sono suggerite da sottili venature biancastre
riempite da fasci fíliformi o fibrosi di una particolare varietà
di gesso chiamata, con nome assai allusivo, sericolite (Fig. 5). Che cosa, oltre alla sericolite, ci suggerisce
che ci sia una faglia? Il fatto che al di sopra di una certa bancata
non ci sia quella che aspettiamo nella successione regolare, ma ne
ritorni una precedente (naturalmente poi seguita di nuovo dalla
stessa successione). La regola è molto semplice: se non viene
osservato il Principio di Sovrapposizione degli strati (1, 2, 3...
n) deve essere intervenuto qualche accidente che ha turbato l'ordine
iniziale, una faglia appunto, che fa duplicare irregolarmente due
spezzoni corrispondenti di successione (1, 2, 3, faglia, 1, 2, 3).
Questo è molto semplice a dirsi ma assai più complesso da
verificare in natura. Nella Vena del Gesso è abbastanza facile e
anche spettacolare a vedersi, perché gli strati sono ben esposti in
parete, abbastanza diversi fra loro (o almeno in gruppi) e
praticamente individuabili singolarmente, soprattutto i primi cinque
e il sesto. Così, una stratigrafia di dettaglio che risolve
spessori di alcuni metri, consente di misurare lo spostamento
relativo dei vari blocchi lungo le faglie fino alla precisione della
decina di metri. Un controllo stratigrafico così preciso ci
consente di dire anche quando certe faglie si sono attivate,
osservando quali sono gli strati che esse tagliano e gli strati che
invece le ricoprono indisturbati.
Una indagine accurata di questo tipo
ci ha permesso di individuare le tappe salienti di questa storia
deformativa, che accenniamo per sommi capi.
1) Non erano tempi molto pacifici,
geologicamente parlando, quelli in cui, verso la metà del
Tortoniano, sui 9 milioni di anni fa, si stavano preparando le
condizioni per trasformare il bacino profondo della Marnoso-arenacea
in una serie di lagune evaporitiche (Fig. 6). Circa un milione di anni prima, il fronte
della catena appenninica in formazione si era avvicinato molto
all'attuale confine tosco-romagnolo (con la fase deformativa detta
appunto "toscana"). C'era ancora instabilità, connessa
con questo avanzamento del fronte della catena, sia sul fianco
interno che su quello esterno del bacino di avanfossa della
Marnoso-arenacea. Sul fianco interno, vicino al confine toscano, dal
fronte della catena si distaccavano grandi frane sottomarine che
interponevano ai sedimenti normali della Marnoso-arenacea dei
materiali di origine ligure (tipo Argille Scagliose), chiamati
appunto "olistostromi liguri". Sul fianco esterno, verso
l'Adriatico, dove iniziava 1'"avampaese" indeformato e non
subsidente, si trovava una specie di cercine o rialzo periferico
dell'avanfossa che, per effetto dell'avanzamento della catena,
tendeva a smembrarsi e a spostarsi più verso nord-est (Fig. 7).
Così, su di esso, dove in seguito si
sarebbe formata la Vena del Gesso, nei sedimenti argillosi della
parte più alta della Marnoso-arenacea si sviluppavano grandi
smottamenti sottomarini a spese di materiale esclusivamente locale
(chiamati slumps o frane in traformazionali). Attività dello
stesso tipo è segnalata anche da frane sottomarine un po' minori
che coinvolgono successivamente i primi calcari stromatolitici. Nel
suo complesso, questa attività di smembramento del rialzo
periferico (che viene indicata come "tettonica a blocchi"
per trazione o estensione) sembra aver delimitato bacini tipo lagune
(come nella Vena del Gesso) da bacini più profondi (come in Romagna
orientale e nelle Marche) appena è sopravvenuta la crisi di salinità.
Che l'attività tettonica controllasse in maniera imponente la
sedimentazione è manifesto in maniera singolare in depositi noti
come "calcari a Lucina ". Essi formano, per
lo più, delle serie di ammassi dal metro alla decina di metri
apparentemente dispersi dentro le argille pre-evaporitiche, ma
allineati a rosario lungo delle faglie. Le Lucina sono grossi
molluschi adatti a vivere su fondali tranquilli marnoso-argillosi (Fig.
8). Si riteneva che il loro aspetto lentiforme
dentro le argille derivasse proprio da scivolamento dal ciglio con
caduta al piede delle scarpate sottomarine prodotte da queste
faglie. Oggi si pensa invece che le lenti a Lucina si siano
formate direttamente in prossimità delle faglie. Infatti, in
analogia a quanto recentemente scoperto in varie parti dei fondi
oceanici e marini caratterizzati da faglie, ricche esalazioni di
metano, idrogeno solforato e altri gas risalgono lungo le faglie e
sono in grado di fornire le condizioni alimentari adatte allo
sviluppo di una catena di organismi, spesso ipertrofici, anche al di
fuori del loro normale ambiente di vita. Se ci limitiamo a leggere
la storia nel tratto meglio esposto della Vena del Gesso, dall'alto
Sellustra al Lamone, possiamo individuare le altre tappe (Figg. 9
e 10).
2) Per tutto il tempo corrispondente
ai primi sei cicli delle evaporiti le condizioni sono rimaste
sostanzialmente tranquille e la subsidenza è stata regolare in
tutta l'area con massimi relativi nella valle del Senio. Ce lo
testimonia la regolare e costante presenza di tutti i primi sei
banchi.
3) Dopo il sesto ciclo, invece, deve
essere capitato qualcosa di importante, che ha sconvolto l'unitarietà
del bacino. Infatti oggi noi vediamo certe colline e certe montagne
della Vena del Gesso nelle quali si possono contare tutte le bancate
gessose più sottili al di sopra della sesta (per esempio a Monte
Mauro, al Rio Stella, al Rio Sgarba e alla Paradisa di Borgo
Tossignano). Altre, invece, ne sono prive, in parte o del tutto
(come al Monte Penzola, al dirupo di Sasdello sul Santerno, a
Tossignano e alla Torre dell'Orologio in Brisighella). Se andiamo a
vedere i rapporti fra le rupi dove la successione dei cicli gessosi
è completa e dove non lo è, troviamo le faglie verticali, di cui
s'è detto. Queste separano blocchi delle dimensioni dal mezzo
chilometro ad alcuni chilometri, rialzati e abbassati relativamente
uno all'altro. L'area dal Monte Penzola al Rio Sgarba è la più
adatta per fare questo tipo di osservazioni. Il lettore attento e
ormai allenato a porsi i dilemmi di queste ricostruzioni della
storia geologica si chiederà se questo alzarsi e abbassarsi di
blocchi, documentato dalle faglie che li dividono, sia avvenuto
prima della formazione dei cicli successivi al sesto o se invece
abbia avuto luogo solo al termine dell'ultimo ciclo gessoso, durante
la fase di emersione di cui abbiamo già parlato. Nel primo caso,
nei blocchi rialzati i cicli postsesto non si sarebbero mai deposti;
nel secondo, invece, sarebbero stati erosi. Probabilmente sono
avvenuti tutti due questi processi. La prova del primo, comunque, ci
è fornita da esempi spettacolari dentro la grande Cava ANIC di
Borgo Rivola, dove si vedono alcune faglie verticali, orientate come
quelle che separano i blocchi, che sono sigillate dall'ottavo ciclo,
per cui devono essersi attivate prima.
4) Così, solo nei blocchi che si
trovavano in subsidenza si è formata la successione completa dei
cicli evaporitici, mentre sugli altri non c'è stato deposito, anzi
può essersi manifestata erosione. Può essere capitato anche che
dal ciglio di questi blocchi in sollevamento pezzi di bancate
gessose instabili siano cadute dentro alle lagune circostanti. Li
troviamo oggi, ad esempio nel Parco Carnè, in forma di massi delle
dimensioni dal metro alla decina di metri, che appaiono isolati e un
po' alieni all'interno di bancate gessose di cui non hanno le
caratteristiche. Anche l'inondazione salmastra che iniziò la
Formazione a Colombacci raggiunse solo i blocchi subsidenti,
risparmiando quelli rialzati, almeno per un certo tempo.
5) Poi, all'improvviso, nel breve
volgere di 100 o 200 mila anni, avviene la rivoluzione tettonica di
cui si è accennato prima (Fig. 11) Tutta la Vena del Gesso, compresa la porzione
sepolta nel sottosuolo fin quasi all'Imolese, viene incorporata al
fronte di una vasta fascia soggetta a compressione, da cui si
originerà la porzione detta intramessiniana della Catena
Appenninica. Si immagini il lettore l'effetto di un ragazzotto
mattacchione, che irrompa nel salotto buono e cerchi di frenare la
sua corsa, senza riuscirci, proprio sul tappeto persiano.
Succederà che il tappeto ne attutirà
l'urto ripiegandosi a soffietto in maniera multipla e asimmetrica,
accorciandosi rispetto alla lunghezza iniziale. Un qualcosa di
simile è capitato anche qui, con pieghe così brusche da arrivare
fino allo strappo, verso l'Adriatico, e spesso anche al
controstrappo, verso l'Appennino. Questa viene chiamata
"tettonica compressiva tangenziale", perché origina delle
superfici di strappo (taglio) tangenti o quasi parallele alla
superficie terrestre. Gli effetti di questa tettonica sono ben
visibili nelle duplicazioni e triplicazioni della successione
regolare delle bancate evaporitiche della Vena del Gesso. L'esempio
più spettacolare è quello esposto proprio sulla cima del Monte
Penzola, dirimpetto a Fontanelice. Qui c'è duplicazione della
successione evaporitica sopra al sesto ciclo e si può osservare
direttamente la superficie dove è avvenuto lo strappo che ha
portato a una sovrapposizione della porzione strappata secondo un
piano quasi orizzontale (Fig. 12).
Come si riesce a dire che questa
intensa deformazione compressiva è avvenuta nel Messiniano? Usando
il classico criterio della discordanza. Infatti, in campagna, ad
esempio sopra le duplicazioni del Torrente Sintria (sezioni
geologiche in Fig. 15) o nei dintorni di Rineggio, troviamo la
parte alta delle Formazioni a Colombacci disposta come a sigillare
le superfici di strappo, o le faglie verticali che separano i
blocchi. I movimenti relativi fra i blocchi, così come gli strappi
con relative duplicazioni, devono essere avvenuti perciò prima del
Messiniano superiore, perché la Formazione a Colombacci non ne è
stata interessata, almeno da un certo momento in poi.
6) Il primo più importante evento
nella costruzione dell'Appennino Romagnolo si è così compiuto nel
Messiniano superiore. Ma altri lo hanno seguito. La storia
deformativa, infatti, non si è esaurita in quell'evento. pur tanto
importante; essa è perdurata per i cinque milioni di anni
successivi, ancora intensa, ma in progressiva diminuzione (Figg.13
e 14). Come facciamo a dirlo? Basta guardare
alle Argille Azzurre, che formano la gran parte dei nostri calanchi.
A dire il vero, qui non è così facile distinguere gli strati come
nella Marnoso-arenacea o nella Vena del Gesso. Per prima cosa,
bisognerebbe decorticare le frastagliate pareti dei calanchi dalla
sottile crosta di argilla che le riveste per colamento durante le
piogge. Poi, anche allora gli strati si intravvederebbero talora con
fatica. Quanto basta, però, per vedere che non sono orizzontali ma
inclinati, in modo spesso marcato, specialmente quelli più antichi
di circa 3 Ma. Sono un po' meno inclinati, invece, quelli di età
compresa fra 3 e 1 Ma. Dobbiamo ammettere allora che ci siano stati
altri eventi durante i quali i nuovi strati deposti sono stati
deformati, anche se in maniera meno violenta dei precedenti. I
quali, naturalmente sono stati rideformati insieme ai nuovi; come
dimostrano faglie che tagliano indifferentemente rocce di età
messiniana e pliocenica.
7) A ben guardare, però, neanche gli
strati più recenti di 1 Ma sono completamente indisturbati (Figg. 13 e 14). Essi non mostrano certo nè pieghe nè
inclinazione maggiore di quella che avevano al momento della
sedimentazione. Spesso, però, sono fagliati e, in ogni caso, in
pianura sono sprofondati mentre al bordo pedeappenninico sono stati
sollevati fino a 300 metri sul mare. Faglie con movimenti relativi
di un metro sono state trovate addirittura in alluvioni fluviali di
20-30 mila anni fa.
|