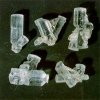|
|
|
3 Morfologia e Carsismo Gian Paolo Costa, Paolo Forti IL PAESAGGIO NEI GESSI I gessi selenitici messiniani affiorano, discontinui, lungo il margine pedeappenninico da Reggio Emilia sino al confine con le Marche ed oltre. Fra tutte le emergenze gessose la Vena del Gesso romagnola, compresa tra l'Imolese e il Faentino, è quella più consistente e morfologicamente unitaria (il 70% degli affioramenti della Formazione Gessoso-solfifera appartiene alla dorsale della Vena). A grande scala l'importanza paesaggistica dei Gessi è dovuta al fatto che sempre essi si trovano in posizione elevata sui litotipi circostanti e pertanto i rilievi gessosi svettano e risultano ben visibili all'orizzonte sia che ci si diriga verso la dorsale provenendo da nord, cioè dalla pianura, sia che li si raggiunga da sud, dalle parti più interne dell'Appennino. In particolare, osservata da sud la bianca, continua scogliera selenitica esercita un fascino unico. La cosa potrebbe apparire a prima vista assai strana, dato che la solubilità intrinseca del gesso è molto elevata (oltre 2 grammi/litro) e di conseguenza apparirebbe logico che la demolizione della roccia gessosa affiorante, ad opera delle acque meteoriche, avvenisse con maggiore rapidità di quella delle formazioni limitrofe (Formazione Marnoso-arenacea ed Argille Azzurre plioceniche). In realtà avviene l'esatto opposto poiché tutti i litotipi adiacenti ai Gessi sono sottoposti ad una erosione meccanica di gran lunga più intensa. La spiegazione è relativamente semplice: il gesso è una roccia carsificabile e pertanto vige, come accade per le rocce calcaree, il ben noto principio dell'inversione del rilievo (Geze, 1969). In pratica nelle aree di affioramento delle rocce carsificabili il ruscellamento di superficie è insignificante: le acque meteoriche vengono "assorbite" in modo diffuso dalla roccia, all'interno della quale poi scavano condotti più o meno grandi (le grotte, appunto). L'usuale evoluzione geo-morfologica porta ad avere le formazioni carsificabili sempre emergenti su tutte le altre: la Vena del Gesso romagnola non costituisce un'eccezione. |
|
|
|
LE FORME CARSICHE SUPERFICIALI Avvicinandosi agli affioramenti gessosi o camminando su di essi è inevitabile imbattersi in grandi depressioni chiuse quali le valli cieche o le doline. Le valli cieche sono morfologie che si sviluppano in litotipi non carsificabili al contatto con rocce "permeabili per carsicità" In questi litotipi il ruscellamento delle acque meteoriche incide normali valli fluviali fino al punto in cui emerge la roccia carsificabile, nel nostro caso il gesso, più facile da "forare" che da scavare. Pertanto sul fondo di queste valli si aprono uno o più inghiottitoi attraverso i quali l'acqua penetra nell'affioramento carsico. Nella Vena del Gesso esistono due splendidi esempi di valle cieca: la valle della Tana della Volpe, a ridosso di Brisighella, e la spettacolare valle del Rio Stella, sbarrata dalla dorsale gessosa tra Monte Mauro e Monte della Volpe. In entrambi i casi è possibile, anche se tutt'altro che agevole, percorrere l'intero tratto ipogeo compreso tra il punto di inghiottimento delle acque e quello di risorgenza dalla parte opposta dell'affioramento gessoso, dove riprende la tipica morfologia vallivo-fluviale. Nell'Imolese la gola del Rio Sgarba è probabilmente quanto resta di un antico traforo ipogeo connesso ad una valle cieca. L'altra forma carsica di grandi dimensioni assai diffusa nei gessi della Vena è la dolina. Le doline sono depressioni generalmente imbutiformi, prodotte dalla dissoluzione della roccia ad opera delle acque di precipitazione meteorica: di norma presentano al fondo una cavità assorbente subverticale in cui si riversano tutte le acque piovane raccolte dalla dolina stessa. La superficie e la profondità delle doline sono molto variabili. Nei gessi messiniani dell'Emilia-Romagna si va da pochi metri di diametro e di profondità fino a valori che sfiorano i 500 m di diametro e oltre i 100 di profondità (dolina della Spipola, nel Bolognese). Nella Vena del Gesso romagnola una delle doline più caratteristiche è senza dubbio il cosiddetto Catino di Pilato, ai piedi del Monte di Rontana. Ha la forma di un cratere a fondo piatto (e sono molti coloro che vedendolo pensano immediatamente ad un cratere vulcanico!); al bordo settentrionale della dolina si apre la cavità inghiottitoio: l'Abisso Fantini. A poche centinaia di metri dal Catino è osservabile, da posizione panoramica, un bell'esempio di morfologia carsica a doline rappresentato dal territorio del Parco Carnè. Tra le doline ad imbuto è da ricordare quella del Noce, sul cui fondo si apre la grotta omonima. In realtà sia la dolina del Fantini che quella del Noce, pure tipiche per forma, sono un poco anomale in quanto non si aprono interamente nel gesso ma al contatto fra due litotipi (rispettivamente gesso-sabbie marnose e gesso-argilla). Lo sviluppo delle doline è spesso controllato dalle lineazioni tettoniche: faglie e sistemi di fratture facilitano l'infiltrazione delle acque all'interno della roccia gessosa. E' facile, per questo motivo, osservare doline allineate secondo una direzione ben precisa, appunto quella del disturbo tettonico che ne ha condizionato e ne condiziona la storia evolutiva. Nell'area di Monte Mauro, ma non solo qui, esistono significativi allineamenti di doline, anche molto grandi, in particolare secondo assi SSE-NNO. Pur raggiungendo, come abbiamo appena visto, dimensioni ragguardevoli, gran parte delle morfologie macroscopiche dei Gessi sono giovani, essendo nate a partire dal tardo Quaternario quando l'erosione differenziale (con conseguente inversione del rilievo) ha cominciato a fare emergere i Gessi dalle formazioni vicine, argillose a valle ed sabbioso-marnose a monte. Ancora oggi l'evoluzione geomorfologica locale è molto rapida e provoca, in breve arco di tempo, la nascita di nuove piccole doline e l'apertura di nuovi pozzi assorbenti. A grande scala le modalità evolutive del paesaggio nei Gessi sono le medesime non solo per l'intera Vena del Gesso romagnola, ma per tutti gli affioramenti evaporitici dell'Emilia-Romagna (Forti & Francavilla, 1988); sono schematizzate nelle Figg. 4 e 5. Mentre la Vena andava "emergendo" la rete di drenaggio superficiale (Fig. 4a), impostata sulle linee di discontinuità esistenti, iniziava la suddivisione in blocchi della dorsale gessosa. 1 fiumi principali possedevano sufficiente energia per tagliare da parte a parte i Gessi mentre questi si sollevavano (sia in senso assoluto che relativo), per allargare le loro valli e mantenere un percorso subaereo. I torrentelli minori avevano assai meno energia e di conseguenza i loro bacini si "isolavano" in forma di valli cieche, alimentando cavità o sistemi carsici sotterranei (Fig. 4b). Contemporaneamente iniziava la formazione di doline nella parte superiore degli affioramenti gessosi, ove peraltro restavano fossilizzati alcuni tratti di paleovalli fluviali: è il caso della sella di Ca' Faggia, tra Monte Mauro e Monte della Volpe (sotto la quale si sviluppa il sistema Rio Stella-Rio Basino) e della sella di Ca' Budrio, tra Sasso Letroso e Monte del Casino. L'approfondimento delle valli principali ovviamente provocava un progressivo abbassamento del locale livello di base carsico, innescando l'apertura di nuovi inghiottitoi e risorgenti a quote meno elevate: le acque sotterranee abbandonarono così lunghi tratti di gallerie, in alcuni casi ancor oggi perfettamente conservati "in quota" (è il caso della Tana del Re Tiberio, risorgente fossile). Qualora, ed è la situazione attuale, rallenti la velocità di abbassamento del livello di base e quindi la velocità dell'escavazione fluviale, l'evoluzione delle valli subaeree è essenzialmente il risultato dell'erosione regressiva, mentre le grotte si ampliano anche a seguito di processi di condensazione, molto più lenti, attivi sulle volte. Questi due fenomeni paralleli causano la parziale o totale trasformazione dei fiumi sotterranei in superficiali, con la creazione di nuove valli secondarie, spesso a forra (Figg. 4d, 5). Queste ultime, nel caso si riattivi una fase di approfondimento vallivo sufficientemente rapido, possono a loro volta essere abbandonate in tale stato dall'acqua, alla continua ricerca di percorsi più diretti (ne è un esempio il paleoalveo a cielo aperto della Tanaccia, più noto con il nome di Buchi del Torrente Antico). L'evoluzione verso la morfologia "a forra", indice di un carsismo senescente, risulta praticamente completata nei gessi triassici dell'alta valle del Secchia, mentre nei gessi messiniani ed in particolare nella Vena del Gesso romagnola è ancora in corso o appena cominciata: esistono infatti nella Vena vari tunnel idrogeologici, alcuni dei quali parzialmente trasformati in canyons (v. Fig. 5). L'esempio più eloquente di carsismo regressivo "verso monte" dei sistemi carsici nei Gessi della Vena è fornito dal complesso Rio Stella-Rio Basino (Forti et al., 1987), dove la stretta forra che ha inciso le ultime bancate di gesso verso la pianura presenta ancora alcuni passaggi in sotterraneo. Analoga, anche se evolutivamente più avanzata, era la forra del Rio Sgarba, prima della parziale distruzione causata dalla Cava SPES. Esistono chiare interrelazioni tra gallerie carsiche, livelli di sorgenti, terrazzi fluviali e variazioni del livello del Mare Adriatico, le quali sembrano indicare che la carsificazione dei Gessi, quale attualmente vediamo, sia iniziata nell'Emilia-Romagna solo poche centinaia di migliaia di anni addietro e che comunque i fenomeni conobbero il loro maggior sviluppo nell'ultimo postglaciale, essenzialmente durante i periodi caratterizzati da forti precipitazioni. |
| Fig. 1 - La valle del Sintria e l'affioramento gessoso di Monte Mauro visti da SE. (foto G.S.F, I. Fabbri). |
| Fig. 2 - La falesia gessosa che sbarra la valle del Rio Stella. (foto G.S.F, I. Fabbri). |
| Fig. 3 - Profonda dolina a fondo piatto nell'affioramento gessoso di Monte Mauro - Monte della Volpe. In quest'area le doline sono allineate lungo evidenti linee tettoniche. (foto G.S.F.). |
| Fig. 4 - Schema evolutivo di un'area carsica gessosa: a: stadio iniziale; b: drenaggio sotterraneo delle acque di scorrimento superficiale a contatto con il gesso; c: sviluppo parallelo delle valli subaeree e delle cavità naturali; d: formazione di nuove valli secondarie. |
| Fig. 5 - Evoluzione verso monte delle sorgenti carsiche con sviluppo di valli cieche: a) approfondimento delle valli sbarrate con formazione di vari livelli di gallerie; b) evoluzione verso monte delle sorgenti. |
| Fig. 6 - Forra nella parte distale del corso del Rio Basino (foto G.S.F., G.P. Costa). |
|
|
|
LE MICROFORME CARSICHE SUPERFICIALI L'alta solubilità del gesso rispetto a quella del calcare e la sua grana cristallina, che normalmente raggiunge nel gesso selenitico dimensioni centimetriche, fanno sì che le microforme superficiali (karren, kemenitze, etc.), così comuni nelle aree carsiche classiche, nella Vena del Gesso siano piuttosto rare (Forti, 1987). Infatti sono state osservate in ristretti ambiti e quasi sempre ad uno stadio embrionale. In genere si trovano in zone di affioramento degli strati gessosi stratigraficamente più alti, di spessore ridotto ed in gran parte costituiti da cristalli risedimentati di dimensioni millimetriche. Per quanto riguarda i karren, i caratteristici solchi di dissoluzione assai diffusi nelle aree carsiche calcaree ("campi solcati"), sono osservabili in località Crivellari, sopra Borgo Rivola. Anche qui affiorano gli strati terminali della successione gessosa. Di contro le caratteristiche tipiche dei gessi messiniani hanno permesso lo sviluppo di forme assolutamente peculiari quali le candele e le bolle di scollamento. Le prime sono forme di dissoluzione-erosione ben note da tempo nei Gessi emiliano-romagnoli, essendo state descritte già nel secolo scorso (Capellini, 1876). Si tratta di solchi subverticali, profondi anche un metro e alti sino a 10 metri, che si sviluppano attorno agli imbocchi degli inghiottitoi sovrastati da ripide pareti di roccia viva sulle quali, per la mancanza di copertura vegetale, l'acqua può ruscellare con una certa energia. Sono molto belle le candele presenti all'interno del Parco Carnè. L'altra forma peculiare, la bolla di scollamento, pur essendo assai diffusa non solo nella Vena del Gesso romagnola ma in tutti gli affioramenti gessosi di età messiniana, non era stata presa in alcuna considerazione sino a pochi anni or sono (Forti, 1987). Le bolle di scollamento sono rigonfiamenti sferoidali, o più frequentemente ellissoidali, delle bande cristalline più superficiali di uno strato di gesso; si formano esclusivamente nelle zone dove la roccia è scoperta e di norma, ma ciò non è strettamente necessario, la stratificazione è sub-orizzontale. Per la "crescita" di queste strutture è necessario che la stratificazione interna al banco gessoso non sia molto potente (mai superiore ai 50-60 centimetri). Inizialmente si verifica lo scollamento progressivo di un livello corticale rispetto a quello immediatamente sottostante: questo distacco è facilitato se tra le bande cristalline coinvolte esiste un anche minimo velo argilloso. La parte centrale si innalza, sempre ad opera delle spinte compressive laterali che si sviluppano per l'aumento di volume di questo straterello: aumento di volume a sua volta determinato dalla disarticolazione del tessuto cristallino per l'azione combinata degli agenti meteorici (umidità, variazioni di temperatura, piogge). Spesso alla sommità della bolla troviamo dei fori subcircolari che, nei casi di maggiori dimensioni, permettono di entrare all'interno della stessa. Con il passare del tempo il progressivo ampliarsi del foro sommitale provoca la demolizione totale di questa morfologia che forse è quella, sui gessi, a più rapido sviluppo (si calcola che l'evoluzione completa, dall'iniziale distacco alla distruzione totale della bolla, non comporti più di qualche centinaio di anni). |
| Fig. 7 - Particolare di karren nei gessi di Monte Mauro - Monte della Volpe. (foto G.S.F., G.P. Costa). |
| Fig. 8 - Area con karren particolarmente sviluppati: Gessi di Sasso Letroso - Monte del Casino. (foto G.S.F., G.P. Costa). |
| Fig. 9 - Bell'esempio di sviluppo di candele all'interno dell'area del Parco Carnè. (foto G.S.F., G.P. Costa). |
| Fig. 10 - Grandi bolle di scollamento nei Gessi di Sasso Letroso - Monte del Casino. (foto G.S.F., G.P. Costa). |
|
|
|
IL CARSISMO PROFONDO Se nelle forme superficiali il carsismo nei gessi messiniani evidenzia differenze e peculiarità rispetto a quello nei calcari, più noto e studiato, è sicuramente il carsismo sotterraneo a manifestare tutta la sua originalità. La Vena del Gesso romagnola occupa un posto di primaria importanza tra le aree carsiche, ospitando tra l'altro alcune grotte record in gesso: la grotta più profonda del mondo (l'Abisso F10, sulla sella di Ca' Faggia, vanta una profondità di 210 metri) ed il secondo traforo idrogeologico per importanza in Europa (il sistema carsico Rio Stella - Rio Basino). Le rocce gessose, in particolar modo quelle macrocristalline (quali la selenite della Vena del Gesso) sono assai poco permeabili per porosità. L'infiltrazione prima e la circolazione ipogea poi avvengono esclusivamente lungo linee strutturali, che essendo di norma vie di facile penetrazione e scorrimento indirizzano e controllano lo sviluppo del carsismo. Questa relazione tra tettonica e fenomeni carsici appare ben evidente se si raffrontano le direzioni di allungamento delle principali cavità carsiche con l'andamento delle linee di disturbo tettonico presenti nell'area (Finotelli et al., 1986). In questo senso l'evoluzione del carsismo nei gessi risulta essere relativamente di più "semplice" lettura di quella nelle rocce carbonatiche dove, pur essendo sempre molto forte, il controllo strutturale non è totale, influendo anche, in alcuni casi (Passeri, 1968), la porosità primaria. L'elevata solubilità dei gessi (circa 2 g/l) e la loro facile erodibilità meccanica ad opera di flussi canalizzati (soprattutto lungo le superfici di strato), fanno sì che lo sviluppo dei condotti sia generalmente veloce, con tempi di circa due ordini di grandezza inferiori a quelli richiesti in ambiente carbonatico. Ciò comporta la formazione "rapida" di gallerie che collegano direttamente i punti di immissione ai recapiti, con la creazione di cavità molto semplici e poco ramificate. La velocità con la quale vengono modellate le condotte carsiche ha come conseguenza da una parte il dimensionamento delle stesse sulle massime portate possibili (cioè quelle di piena), il ché impedisce oscillazioni di un qualche rilievo della falda, anche sospesa, dall'altra la formazione di cavità carsiche a più livelli che si sviluppano di mano in mano che la quota dei recapiti varia per approfondimento o innalzamento del livello di base. Il raggiungimento dell'equilibrio con un nuovo livello di base richiede in genere tempi ridotti, anche se questi possono variare da luogo a luogo in funzione della portata del corso d'acqua sotterraneo e del gradiente idraulico. A questo proposito nel sistema Spipola-Acquafredda, nel Bolognese, si è potuto osservare come a causa di un abbassamento della superficie della falda di circa 10 metri nell'area della risorgente, abbassamento repentinamente indotto dai lavori di una cava, si è attivato un rapido processo speleogenetico controcorrente; dopo appena 10 anni il fiume sotterraneo, anche nei periodi di piena, non scorreva più nel suo vecchio alveo fino ad oltre 500 metri dal recapito, mentre in magra risultava secco per ulteriori 300 metri Se ne può dedurre che condotte carsiche dimensionate per portate di almeno 200 l/s (tale è la portata di piena del sistema ricordato) siano state "scavate" alla velocità di circa 50 metri l'anno (Forti & Francavílla, 1990). L'elevata velocità di scorrimento e di raccordo con il livello di base locale fa sì che le maggiori grotte nei gessi siano caratterizzate in genere da lunghe condotte suborizzontali, collegate ai punti di immissione da pozzi verticali. Un'altra particolarità delle cavità carsiche nei gessi consiste nel fatto che esse, a differenza di quanto può verificarsi nei calcari, arrestano il loro sviluppo alla quota del livello di base o pochi metri al di sotto di esso (Calaforra & Forti, 1992): non esistono infatti meccanismi speleogenetici in grado di carsificare le rocce gessose nella zona satura, se si esclude quello (peraltro molto raro) derivante dalla iniezione di acque profonde non solfate. |
|
|
|
I PRINCIPALI MECCANISMI DI FORMAZIONE DELLE GROTTE Abbiamo già accennato in precedenza al fatto che perché si abbia carsificazione profonda nei gessi è necessario che l'acqua possa penetrarvi attraverso fratture beanti, sottolineando come la speleogenesi nella Vena del Gesso sia controllata dalle varie situazioni strutturali locali. Tuttavia, a causa dell'elevata solubilità della roccia, in genere le originarie morfologie tettonico-strutturali non si conservano oppure non sono individuabili negli ambienti ipogei: infatti è sufficiente il passaggio di una piccola quantità d'acqua per un tempo relativamente modesto per mascherarne ogni traccia, sostituita con forme di chiara origine dissolutiva o modificata dai crolli. E' comunque spesso agevole identificare e rilevare litoclasi, diaclasi, e piccole dislocazioni: splendido l'esempio costituito dalla faglia, a rigetto metrico, che attraversa la Sala Quarina nella Grotta di Onferno. L'allargamento delle lineazioni tettoniche che innescano la carsificazione è in primo luogo opera della dissoluzione semplice. Per farsi un idea di quanto la dissoluzione possa essere efficace, basti pensare che nel sistema Rio Stella - Rio Basino (Forti et al., 1989) scorre un fiume sotterraneo, con portate medie di oltre 10 l/s: tenendo conto della velocità con la quale si raggiunge l'equilibrio di solubilizzazione, ogni secondo dal sistema escono circa 40 grammi di roccia, il ché teoricamente porta, nell'arco di un anno, alla creazione di un vuoto corrispondente ad un cubo di circa sette metri di lato. A questo processo carsogeno, di gran lunga il più efficace, si affiancano, in ordine di importanza quantitativa, la corrosione per condensazione (Cigna & Forti, 1986) e l'effetto dell'anidride carbonica disciolta (Forti & Rabbi, 1981). L'azione corrosiva esplicata dalla condensazione ha luogo quando aria esterna calda e umida entra in ambienti (quelli di grotta) più freddi e, diminuendo la sua temperatura, diviene sovrasatura di vapor acqueo che condensa sulle pareti e soprattutto sulle volte delle cavità. L'acqua così depositatasi è ovviamente pressoché distillata e pertanto risulta assai aggressiva nei confronti della roccia gessosa. Il clima continentale temperato, caratteristico dell'Emilia-Romagna, fa sì che questo effetto sia particolarmente marcato, al punto che calcoli fatti per il sistema carsico della Spipola, nei Gessi bolognesi, hanno dimostrato come nell'arco dell'anno questo effetto sia responsabile della dissoluzione di ben 5 metri cubi di roccia gessosa, valore che rappresenta circa il 2-3% della dissoluzione complessiva riscontrata in tutto il bacino della grotta (Cigna & Forti, 1986). Le condizioni climatiche nell'area della Vena del Gesso e le modalità della circolazione dell'aria all'interno delle sue grotte sono essenzialmente analoghe a quelle esistenti nel Bolognese e pertanto tali risultati sono estensibili anche a questo "comprensorio carsico". L'ultimo processo speleogenetico è dovuto alla presenza di anidride carbonica nelle acque di infiltrazione. Quando queste acque raggiungono i gessi ed iniziano a dissolverli, immediatamente si instaura una serie di equilibri chimici (v. Fig. 13) che, portando alla deposizione di concrezioni di carbonato di calcio (sale molto meno solubile del gesso), causano una solubilizzazione di gesso aggiuntiva rispetto ad una solubilizzazione semplice. Questo meccanismo speleogenetico è certamente di gran lunga meno efficace dei due precedenti anche e soprattutto perché la deposizione di una concrezione calcarea bilancia l'ampliamento dei vuoti nel gesso. E' invece estremamente importante per giustificare l'esistenza di una buona parte delle concrezioni carbonatiche all'interno di grotte gessose: infatti molte concrezioni si sono sviluppate e continuano ad accrescersi in grotte scavate nel gesso affiorante e pertanto è da escludere che tali depositi siano collegati alla dissoluzione, da parte delle acque di infiltrazione meteorica, di sovrastanti strati di marne o altri litotipi calcarei. La corrosione dovuta all'anidride carbonica disciolta è inoltre responsabile dell'evoluzione di alcune forme concrezionarie in carbonato di calcio del tutto particolari e assolutamente limitate all'ambiente dei Gessi, delle quali parleremo in un paragrafo successivo. |
| Fig. 11 -Lungo il soffitto della Grotta del Noce è evidente un effetto del disturbo tettonico che ha generato la cavità. (foto G.S.F., I. Fabbri). |
| Fig. 12 - Il torrente che scorre all'interno del complesso carsico Rio Stella - Rio Basino. (foto G.S.F, I. Fabbri). |
| Fig. 13 - Schema delle reazioni che portano all'effetto di carsificazione ad opera di acque carbonatiche sulle rocce gessose. |
| Fig. 14 - Abisso Peroni: grande concrezione carbonatica. (foto G.S.F, I. Fabbri). |
| Fig. 15 - La sezione della galleria principale del Rio Basino presenta andamenti sinuosi caratteristici dell'approfondimento erosivo operato dal fiume sotterraneo. (foto G.S.F, I. Fabbri). |
|
|
|
LE FORME CARSICHE SOTTERRANEE All'interno delle grotte della Vena del Gesso, e dei Gessi romagnoli in genere, possiamo osservare una grande varietà di forme tra le quali le più diffuse ed affascinanti sono quelle tipiche dei tratti di galleria suborizzontali: tra queste sono comuni i meandri che, come nel caso della Tana della Volpe o del Rio Basino, dell'Abisso F 10 o, ancora, di Onferno, a volte si trasformano in veri e propri stretti canyons a pareti sinuose larghi anche pochi decimetri ed alti fino ad alcune decine di metri. Come accennato in precedenza, l'impossibilità pratica del carsismo di spingersi nelle rocce gessose sotto il livello freatico fa sì che nei gessi, a differenza di quanto si verifica nei calcari, le morfologie freatiche siano molto rare. Per di più la rapidità evolutiva delle grotte in gesso non permette il mantenimento di queste classiche forme, presto obliterate da quelle successive sviluppatesi in ambiente vadoso. Tra i pochissimi esempi di tipiche morfologie freatiche, comunque di limitata estensione, possiamo ricordare la condotta forzata a sezione ellittica della Grotta del Ragno, nel Bolognese, e i laminatoi dei rami inferiori della Grotta della Spipola, sempre nei Gessi bolognesi. Nella Grotta di Alien (Brisighella) è stata osservata una breve condotta a sezione perfettamente circolare. Ascrivibile ad una genesi in ambiente freatico è anche il tratto denominato "la Penitenza" nell'Abisso Fantini. Infine esiste un unico esempio di "carsismo sommerso" attivo, di notevoli dimensioni, nella Vena del Gesso: l'affluente a sifone del Rio Basino. La presenza di questo singolare ramo completamente allagato e di ragguardevole portata, la cui esplorazione è stata tentata da vari speleosub senza esiti risolutivi, è senza dubbio da mettere in relazione con le consistenti dislocazioni che interessano localmente l'affioramento gessoso. Nelle zone nelle quali si ha l'intersezione di differenti lineazioni strutturali, ed in particolar modo se queste provocano la convergenza di più flussi idrici e quindi di più gallerie, è facile che vengano a crearsi vasti ambienti di crollo nei quali il soffitto è costituito dalla coalescenza delle varie nicchie di distacco dei blocchi caduti. Il pavimento è invece un accumulo, a volte in forma di conoide, di grossi blocchi di frana di dimensioni generalmente metriche. Il maggiore salone di crollo conosciuto nei gessi messiniani dell'Emilia-Romagna si trova nella Grotta della Spipola nel Bolognese. Di notevole volumetria è, nella Vena del Gesso, il Salone della Tanaccia. Al margine delle fasce, spesso assai ristrette, nelle quali si sono scaricati con maggior forza gli stress tettonici, quindi, nelle immediate vicinanze di faglie di una certa entità, può accadere che banchi gessosi siano stati deformati e forzati a scollarsi (una particolare superficie di debolezza è ovviamente costituita dagli interstrati marnoso-argillosi) ma non risultino troppo fratturati. In tal caso l'avanzare del carsismo può portare alla formazione di sale, anche molto ampie, in cui il soffitto, liscio, non è altro che la superficie basale del banco soprastante mentre il piano di calpestio, altrettanto liscio, è il tetto dello strato che le acque hanno sottoscavato provocandone l'abbassamento (un bell'esempio è rappresentato dalla Sala Piatta della Tanaccia). La Grotta del Noce è in pratica un grande salone di questo tipo: la sezione longitudinale è caratteristicamente triangolare. La sala, che in questo caso si è ampliata per crolli successivi di blocchi, ha un'altezza massima di 12 metri ed una superficie superiore a 260 metri quadrati. I tratti verticali che nelle grotte della Vena collegano tra loro i vari piani sub-orizzontali delle stesse sono in genere costituiti da pozzi, anche piuttosto profondi. Non è raro che uno o più pozzi permettano un "rapido" raggiungimento di profondità in grotte dallo sviluppo modesto, che pertanto possono essere definite a prevalente sviluppo verticale. Per evidenziare questa caratteristica relativa, e non in riferimento a parametri metrici assoluti, sì ricorre all'appellativo di abisso, utilizzato per indicare un consistente numero di cavità carsiche e tettonico-carsiche nella Vena del Gesso romagnola. Spesso la bocca superiore del pozzo è uno stretto pertugio non di rado, prima di lavori speleologici di disostruzione, occultato o addirittura chiuso da fango e blocchi di gesso; generalmente la sezione del pozzo aumenta di dimensioni con la profondità e tende a divenire sempre più circolare: il diametro massimo è alla base, costituita da un pavimento sub-orizzontale ingombro di massi di crollo. Questa morfologia "a campana" è tipica dei cosiddetti pozzi a cascata, scavati dall'acqua che precipitava ed in alcuni casi ancora precipita da un livello superiore ad uno inferiore. Un esempio tipico è rappresentato dal grande pozzo (oltre 40 metri di profondità) che collega la dolina dell'Abisso Peroni, nei Gessi di Rontana e Castelnuovo, al corso d'acqua ipogeo del complesso Fantini-Mornig-Peroni-Cavinale. Se la sezione basale del pozzo ha un'area di varie decine di metri quadrati, l'accesso disostruito nell'ottobre del 1985 è significativamente denominato "Buca da Lettere"! In relazione al locale assetto ed alle caratteristiche dei banchi interessati dal carsismo, il raggiungimento di gallerie a quote inferiori può avvenire attraverso pozzi in successione allineati lungo lineazioni strutturali (Abisso Fantini) e comunque impostati all'incrocio di superfici di debolezza della roccia quali faglie, diaclasi e giunti di strato (inghiottitoio presso Ca' Poggio). Non sono rari "pozzi" (altrimenti indicati con il termine di camini), spesso individuabili solo dal basso, cioè dalle gallerie, assimilabili alle già ricordate candele, a costante sezione circolare e pareti levigatissime al tatto e scintillanti alla luce dell'acetiliene o delle torce. Questi condotti verticali, alti anche più di dieci metri, sono scavati da apporti idrici di scarsa entità ma continui nel tempo. A fianco di queste principali forme vadose e freatiche le grotte in gesso ospitano, con uno sviluppo del tutto eccezionale, morfologie di dissoluzione denominate "canali di volta e pendenti". I canali di volta sono incisioni meandrizzanti dalla caratteristica forma di u rovesciata osservabili su soffitti di galleria suborizzontali, che si sviluppano, differentemente da tutte le altre morfologie da erosione o da dissoluzione, in maniera del tutto indipendente dagli elementi strutturali presenti, quali piani di stratificazione, litoclasi e fratture in genere. La genesi dei canali di volta è stata spiegata in tempi abbastanza recenti (Pasini, 1974). L'acqua, quando scorre con moto laminare molto lento, tende a depositare le particelle fini di argilla e limo che trasporta in soluzione: il pavimento della galleria viene in tal modo preservato da ogni ulteriore corrosione o erosione e l'acqua, a seguito del progressivo accumulo di sedimenti, viene a scorrere a contatto con il tetto della galleria. E, per corrosione/erosione antigravitativa, il flusso idrico provvede a scavarsi un "letto" incidendo il soffitto. Proprio a causa della bassa energia non è inusuale che l'acqua divaghi scavando più canali di volta, tutti di modeste dimensioni, che intersecandosi isolano porzioni gessose simili, ma solo in prima approssimazione, a tozze stalattiti: i pendenti (o anche pseudostalattiti). Nella Tanaccia di Brisighella si trovano alcuni estesi soffitti "a pendenti" di grande fascino e pregio estetico. Queste morfologie divengono visibili e, in certo qual modo, fossilizzano qualora si instauri un nuovo ciclo erosivo classico (cioè gravitativo) e l'acqua, scorrendo con rinnovata energia, provveda ad asportare in parte o in toto i sedimenti fini depositati in precedenza. Da ultimo, pur non essendo forme di origine strettamente carsica, non si può non accennare in questa sede ai "mammelloni" tipici delle rocce gessose e presenti in alcune grotte romagnole, in particolare in quella di Onferno caratteristica per gli imponenti e scenografici soffitti appunto "a mammelloni". I mammelloni sono tozze protuberanze di forma conica e di dimensioni variabili; il diametro di base, come avviene nella Grotta di Onferno, può superare i 2 metri. Sono localizzati nella superficie inferiore dei banchi gessosi; il vertice, verso il quale convergono le estremità dei cristalli di gesso "a ferro di lancia" che costituiscono il mammellone, è sempre rivolto verso il basso. L'origine è sedimentaria: con i mammelloni si apre una fase di deposizione del gesso dopo un periodo di sedimentazione argilloso-marnosa lagunare. La forma conica è frutto dell'aggregazione coalescente a "cavolo" del gesso che cristallizza attorno ai primi nuclei. Questa struttura in rapido accrescimento tende a sprofondare sotto il suo stesso peso nel sottostante livello plastico fino a quando le basi di più mammelloni, via via di superficie sempre maggiore, si saldano tra loro dando origine ad un piano di sedimentazione orizzontale. Poiché i mammelloni non sono comunissimi ed in ogni caso non possiedono il medesimo sviluppo dimensionale è evidente che quest'ultimo doveva essere regolato dalle condizioni sedimentologiche e físico-chimiche locali. In particolare nella Grotta di Onferno, che probabilmente si apre nei banchi basali dove le strutture mammellonari sembrano più diffuse, l'acqua corrente ha provveduto ad evidenziare questa morfologia attraverso il dilavamento diretto ma più spesso inducendo il franamento ed il distacco del materiale marnoso ed argilloso inglobante, creando in tal modo ampi saloni il cui soffitto è movimentato, senza soluzione di continuità, da grandi mammelloni. |
| Fig. 16 - Fase dell'esplorazione speleosubacquea dell'affluente-sifone del Rio Basino. (foto G.S.F, I. Fabbri). |
| Fig. 17 - Grande salone di crollo nel complesso carsico Rio Stella -Rio Basino, (foto G.S.F., I. Fabbri). |
| Fig, 18 - Grande pozzo-cascata nell'Abisso Acquaviva, Gessi di Brisighella. (foto G.S.F., I. Fabbri). |
| Fig. 19 - Canali di volta nei Buchi del Torrente Antico, Gessi di Brisighella. (foto G.S.F., I. Fabbri). |
| Fig. 20 - Soffitto a pendenti nella Sala delle Sabbie all'interno del complesso carsico della Tanaccia. (foto G.S.F., I. Fabbri). |
| Fig. 21 - Soffitto a mammelloni nella Sala del Guano, all'interno del complesso carsico di Onferno (vedi anche Fig. 9 a pag. 24). (foto Archivio Speleoclub Forlì). |
|
|
|
I DEPOSITI FISICI E CHIMICI Gli inghiottitoi e gli ambienti ipogei della Vena del Gesso sono caratterizzati dalla presenza di consistenti depositi fisici (argilla e sabbie, più raramente ghiaie e ciottoli fluitati), che a volte occludono completamente saloni e gallerie raggiungendo spessori anche di vari metri. Mentre la frazione più grossolana dei sedimenti ha un'origine allogenica, è stata cioè trasportata all'interno della formazione gessosa dai fiumi che vi si "ingrottano", diverso è per la frazione più fine. Infatti gran parte di quest'ultima deriva dall'erosione, ad opera delle acque canalizzate sotterranee, degli interstrati marnoso-argillosi che separano i banchi di gesso. Proprio l'abbondanza di depositi a granulometria fine permette il massiccio sviluppo nelle grotte nei gessi messiniani di morfologie quali i canali di volta e i pendenti illustrati in precedenza. A volte i depositi fisici custodiscono testimonianze di estrema importanza che permettono il riconoscimento di fasi particolari della evoluzione climatica e di brani della storia dei popolamenti vegetali ed animali della nostra regione. E' accaduto, ad esempio, con il ritrovamento nei Gessi bolognesi di resti di marmotta e di procione, animali presenti alle nostre latitudini durante l'ultimo glaciale (Cencini, 1965) o, ancora, della fauna di Brisighella (Costa et al., 1985), vecchia di 5,5/5 milioni di anni e preservata in riempimenti di cavità paleocarsiche, indicatrice viceversa di un periodo climatico più caldo dell'attuale. Esistono inoltre, sia all'interno di materiali di riempimento incisi dall'acqua in tempi successivi alla loro deposizione (Bentini, 1972), sia stratificati sopra questi accumuli fisici, ulteriori depositi: quelli archeologici, di origine antropica, che nel complesso dei ritrovamenti ed allo stato odierno delle conoscenze attestano, fino ai giorni nostri, oltre 4000 anni di frequentazione umana delle cavità nei Gessi romagnoli e bolognesi. Passando a considerare i depositi chimici (le concrezioni e le mineralizzazioni secondarie), bisogna premettere che esistono ben pochi studi su quest'argomento incentrati sulle grotte in gesso della nostra regione ed in particolare su quelle della Vena del Gesso romagnola: una delle ragioni di questo dato di fatto può essere ricercata nella vecchia convinzione ben radicata, seppure errata, che tali cavità non solo in Emilia-Romagna ma in tutto il mondo ben poco di interessante avessero da offrire da questo punto di vista. Solo di recente, ed in modo ancora assai frammentario e parziale, si sono intraprese ricerche specifiche che pure hanno evidenziato l'esistenza di speleotemi significativamente diversi rispetto a quelli conosciuti per le grotte in calcare e studiati con maggiore assiduità. Nelle grotte in gesso esistono concrezioni di carbonato di calcio e di gesso. I concrezionamenti calcarei sono abbastanza diffusi e gran parte delle cavità ipogee della Vena del Gesso ne contiene, anche se con localizzazioni che si potrebbero definire puntiformi: esemplificano magnificamente questa situazione alcune superfici concrezionate nella Grotta Tanaccia (Sala del Laghetto), nell'Abisso Peroni, nell'Abisso Mornig (l'imponente parete calcarea, alta più di dieci metri, del Pozzo Farolfi). In generale si tratta di stalattiti, colate, incrostazioni globose, ecc.. Il loro colore varia notevolmente passando da bianco a giallo, a rossiccio, a bruno scuro. Non mancano le pisoliti, altrimenti dette, a causa del loro aspetto e delle modalità di formazione, perle di grotta. Queste concrezioni non mostrano peculiarità rispetto a quelle esistenti, con uno sviluppo molto maggiore, nelle grotte in calcare; sennonché, come si è già accennato, la loro presenza all'interno di grotte in gesso affiorante o comunque non sovrastato da formazioni calcaree pone notevoli problemi di ordine genetico, superabili ammettendo che la deposizione di carbonato di calcio in simili casi sia essenzialmente controllata dall'anidride carbonica disciolta nelle acque di infiltrazione. In tal modo è possibile spiegare non solo l'origine di concrezioni calcaree in molte delle nostre grotte ma anche l'esistenza di croste quasi completamente staccate da pareti gessose a cristalli fortemente corrosi e, ancora, le lame calcaree con nucleo di argilla o fango, spesso di grandi dimensioni, come nell'Abisso Fantini o, nel Bolognese, nella Grotta del Farneto (14 metri di altezza, 2 di larghezza e meno di 20 centimetri di spessore!). E da segnalare l'assoluta rarità di stalagmiti calcaree di dimensioni apprezzabili (decimetriche): ne sono state osservate alcune nell'Abisso F10. Sono ad ogni buon conto gli speleotemi e le cristallizzazioni di gesso a possedere, anche per la loro scarsa distribuzione, i maggiori elementi di interesse. La rarità degli speleotemi gessosi è risultato del particolare clima, con piogge sufficientemente abbondanti e distribuite e temperature non troppo elevate, che non permette una sufficiente evaporazione a livello degli stillicidi: in questo modo la sovrasaturazione rispetto al gesso necessaria alla deposizione delle concrezioni ben difficilmente potrà esser raggiunta. Ciò capita più facilmente in quei luoghi caratterizzati da forti correnti d'aria e stillicidi lenti, condizioni che evidentemente sono state a lungo presenti nella Grotta Calindri nel Bolognese dove si trova un gruppo di grandi stalattiti tutte fortemente deflesse da un forte flusso d'aria proveniente dal paleoingresso (in seguito ostruito per frana). I cristalli di gesso di neoformazione sono invece molto comuni in tutte le grotte dei gessi messiniani e quindi anche in quelle della Vena del Gesso; normalmente si rinvengono all'interno di livelli limosi ed argilloso-marnosi interessati da un lento fluire per capillarità di acque lievemente sovrasature. E impossibile qui descrivere tutte le varietà di tipi e forme cristalline, molto differenti tra loro per abito, dimensioni e limpidezza, che possono essere rinvenute in una delle molte grotte: per una trattazione specifica dell'argomento si rimanda a testi specifici quali Casali et al. (1983) e Hill & Forti (1986). Tra tutti meritano qui di esser ricordati i cristalli aciculari ed i pinacoidi, spesso addensati a rosetta e i grandi "lenticolari", spesso geminati a ferro di lancia, della Grotta Tanaccia. Da ultimo c'è da segnalare un tipo di infiorescenza senz'altro singolare in quanto originata da cristalli di gesso che crescono sopra concrezioni attive di carbonato di calcio: infatti può sembrare del tutto illogico che da una stessa acqua si possano depositare due sali, il gesso e il carbonato di calcio appunto, a diversissima solubilità. Anche la dinamica di questo fenomeno è stata spiegata solo recentemente (Forti & Marsigli, 1978). I meccanismi di precipitazione, pur provenendo in effetti gesso e calcare dalla medesima acqua, sono del tutto differenti: la calcite precipita per la diffusione dell'anidride carbonica dall'acqua all'atmosfera della grotta, mentre il gesso si deposita a causa della sovrasaturazione dovuta all'evaporazione (v. Fig. 29). Oltre a depositi di solfato e di carbonato di calcio (gesso e calcite) ed a veli e masserelle di zolfo amorfo, fino alla stesura di questo contributo non risultavano segnalati altri minerali secondari nelle cavità naturali della Vena del Gesso. Nel corso di una esplorazione in atto (febbraio 1992), a conferma del fatto che la Vena del Gesso romagnola non finisce di regalare sorprese, è stato raccolto un campione di quarzo scheletrico la cui presenza, a stretto contatto con cristalli di gesso secondario, pone nuovi quesiti. Ovvia la conclusione: le ricerche e gli studi intorno alla Vena del Gesso sono tutt'altro che esaustivi, ma ciò che di questo ambiente già conosciamo, anche e soprattutto in campo speleologico, è sufficiente ad affermare che la "Vena" è una perla del nostro Paese, da proteggere e conservare integralmente. |
| Fig. 22 - Lungo i torrenti sotterranei si accumulano sedimenti sia fini che grossolani. (foto P. Forti). |
| Fig. 23 - Grande frammento di anfora romana rinvenuto all'interno dei Buchi del Torrente Antico, nel complesso carsico della Tanaccia. (foto G.S.F., I. Fabbri). |
| Fig. 24 - Pisoliti di carbonato di calcio all'interno della Grotta Lanzoni. (foto G.S.F. I. Fabbri). |
| Fig. 25 - Sottili croste calcaree formatesi per il meccanismo ipercarsico sopra le pareti corrose di un pozzo cascata. (foto L. Donini). |
| Fig. 26 - Perfetto cristallo di gesso ad abito pinacoidale rinvenuto in un paleo inghiottitoio. (foto S. Gnani). |
| Fig. 27 - Cristalli di gesso ad abito prismatico pseudoesagonale rinvenuti in un interstrato argilloso. (foto S. Gnani). |
| Fig. 28 - Infiorescenze gessose su concrezione calcarea della Grotta Lanzoni. (foto G.S.E, L Fabbri). |
| Fig. 29 - Schema genetico per le infiorescenze gessose su alabastro calcareo. L'acqua fluendo sulla concrezione calcarea deposita il carbonato di calcio in eccesso e quindi, risalendo per capillarità sulle infiorescenze e evaporando sulla sommità di queste ultime, deposita il gesso. |
|
|